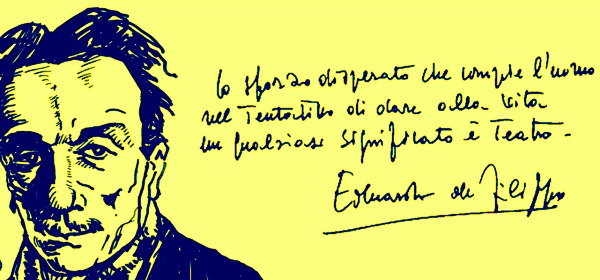La rivolta dei fiumi nell’Italia dalle assoluzioni per tutti

![]() Cantavamo a squarciagola “L’Italia ‘o Paese d’o sole e d’o mare” e c’eravamo dimenticati fiumi e torrenti che serpeggiano attraverso tutta la nostra Penisola. Le alluvioni e i nubifragi tremendi degli ultimi tempi – basta guardare come si è ridotta Chiavari – accompagnano la rivolta dei fiumi.
Cantavamo a squarciagola “L’Italia ‘o Paese d’o sole e d’o mare” e c’eravamo dimenticati fiumi e torrenti che serpeggiano attraverso tutta la nostra Penisola. Le alluvioni e i nubifragi tremendi degli ultimi tempi – basta guardare come si è ridotta Chiavari – accompagnano la rivolta dei fiumi.
Sì, è una rivolta, punto. E’ una vera e propria sommossa anche quella dei torrenti – il Carrione e il Parmignola esondati a Carrara, il Baganza a Parma, il Seveso a Milano – in un incubo collettivo che, per certi versi, assomiglia a quello vissuto dalla comunità di Bodega Bay nel film di Alfred Hitchcock Gli uccelli.
L’ho rivisto qualche giorno fa in versione restaurata: “Signora, assalire è una parola un po’ grossa, non crede? Gli uccelli non hanno mica l’abitudine di assalire la gente senza motivo, no?”.
Se rigiriamo la battuta del celebre film, vien da chiederci perché mai fumi e torrenti dovrebbero avere “l’abitudine di assalire la gente senza motivo”?
Qui non è solo questione di una rivolta dell’ambiente nei confronti di noi sciagurati. E’ la resa dei conti per un Paese come l’Italia, assenteista in ambito prevenzione e colpevole per aver fatto dei “condoni edilizi” una colonna portante della mala politica degli ultimi quarant’anni.
L’Italia è stata messa con le mani nel sacco dall’abusivismo edilizio, da sempre questuante insidioso per raccattare voti in campagna elettorale ed alimentazione del business delle microcriminalità organizzate, oggi complice della brutta fine di quei poveracci, che abitavano in case-baracche poco lontane dai fiumi.
Dopotutto, in quale Paese al mondo esiste un vulcano attivo – il Vesuvio, appunto – sul quale hanno lasciato costruire abitazioni fino ai pressi del cratere?
Chi paga il conto di queste o delle prossime disgrazie? Nessuno. Dal Belpaese in cui “finivano tutti dentro” ci siamo svegliati nel Belpaese dalle assoluzioni per tutti: dagli scienziati del terremoto di l’Aquila ai boss che minacciarono Saviano.
Per tornare ad Alfred Hitchcock, la crudele verità è tutta in questa battuta del film sopra menzionato: “Signorina, gli uccelli non sono aggressivi. Sono il simbolo della gentilezza”.