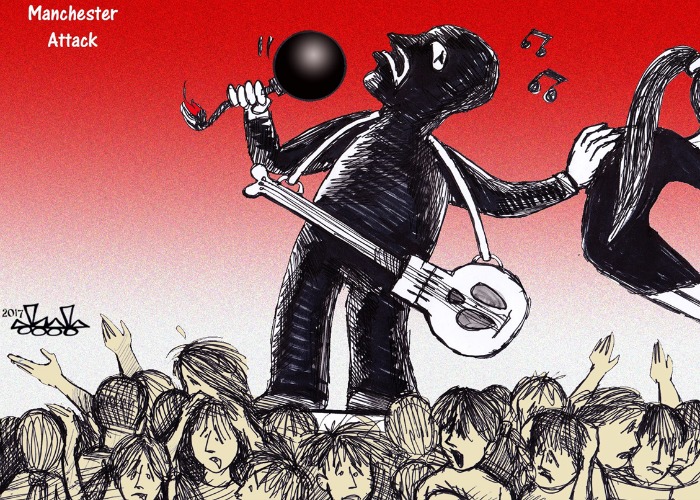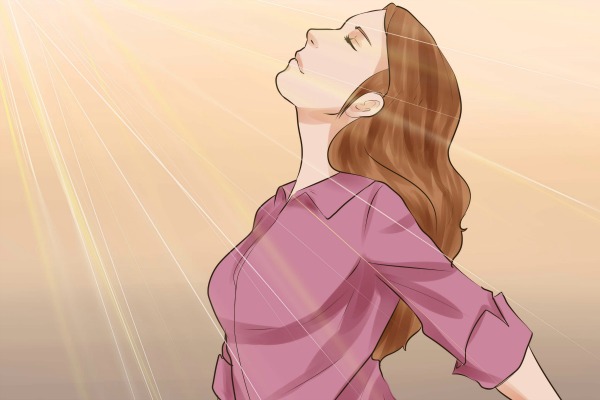L’ergastolo per Piazza della Loggia con le coscienze in ammollo

 Quelli della mia generazione, che si muovevano a carponi nel giorno della strage di Piazza della Loggia a Brescia, sono cresciuti aspettando questa sentenza. Pensavano che l’esito della tragica vicenda del 28 maggio 1974 si chiudesse una volta e per tutte nel raggio del maledetto decennio di piombo.
Quelli della mia generazione, che si muovevano a carponi nel giorno della strage di Piazza della Loggia a Brescia, sono cresciuti aspettando questa sentenza. Pensavano che l’esito della tragica vicenda del 28 maggio 1974 si chiudesse una volta e per tutte nel raggio del maledetto decennio di piombo.
No, la mia generazione è cresciuta con il fiato sospeso, ha visto i tentennamenti della giustizia, ha mandato giù i bocconi amari della Prima Repubblica complice dello stragismo, si è riconosciuta allo specchio con i capelli brizzolati.
Oggi, nel 21 giugno che ci restituisce l’agognata estate, ci risvegliamo con una sentenza in mano arrivata troppo tardi: ergastolo confermato dalla Cassazione per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, i due neofascisti artificieri di uno dei momenti più bui e tormentati della storia della Repubblica italiana.
I due condannati, il primo ultra sessantenne e il secondo ottantenne, sono riusciti a fare un lungo zigzag per scampare una vita dietro le sbarre. Lasciamo in ammollo le nostre coscienze con questo ritardo cronico della Giustizia italiana, incapace di far luce sulle ombre che hanno disegnato la geografia stragista in Italia: Brescia come Bologna, Ustica, piazza Fontana a Milano.
A Maggi e Tramonte, prima o poi, sarà riconosciuto “il diritto alla salute per avvicinarsi ad una morte dignitosa”; ai complici e protettori degli ultimi quarant’anni è stato concesso il diritto di svignarsela; ai parenti delle vittime di piazza della Loggia di continuare a sprofondare in un dolore, in una mortificazione della dignità umana che non passerà perchè nessuno meritava di vivere in uno Stato che fece finta di non vedere.