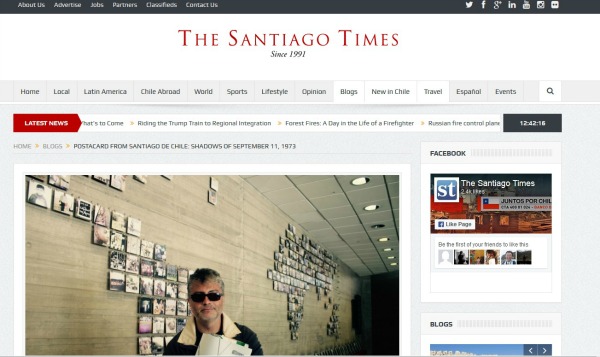Parliamone Sabato? Le donne dell’Est viste dal viaggiatore non sono quelle della Rai

 Una decina d’anni fa, in occasione di un reportage di viaggio nei Paesi dell’Est Europa, mi feci accompagnare all’Università di Varsavia. Incrociai un gruppetto di studenti a cui raccontai questo episodio, chiedendo alla mia guida di tradurre.
Una decina d’anni fa, in occasione di un reportage di viaggio nei Paesi dell’Est Europa, mi feci accompagnare all’Università di Varsavia. Incrociai un gruppetto di studenti a cui raccontai questo episodio, chiedendo alla mia guida di tradurre.
Nella seconda metà degli anni ’80, alla periferia di Napoli dove vivevo, si erano trasferite molte donne polacche per lavorare come badanti e assistere gli anziani. In paese, nell’infelice pregiudizio retrogrado, circolava la voce che quelle femmine dell’Est fossero arpie perché stavano scippando i mariti alle mogli del posto.
Le ricordo il sabato mattina che si ritrovavano alla stazione per andare in gruppo a trascorrere il giorno libero nella vicina Napoli: condivisione dei giorni dalle nostre parti, sospiri nostalgici, mostravano le une alle altre le foto dei figli, dei mariti, dei loro cari.
Le ricordo con profonda commozione in fila all’ufficio postale a depositare i soldi guadagnati da mandare alle famiglie in Polonia. Salutai così gli universitari di Varsavia: “Siete una generazione sveglia, siete il cuore pulsante di questa Europa. Ringraziate e siate fieri delle vostre mamme venute in Italia a faticare per finanziare anche i vostri studi. Io le ho viste con i miei occhi”.
Chissà oggi cosa direbbero gli studenti di allora se sapessero dell’imperdonabile scivolata di Paola Perego e dei suoi autori che ha portato alla chiusura del programma televisivo Parliamone Sabato. Un colpo basso del Servizio Pubblico Televisivo, i cui vertici non si erano accorti dei “sei consigli” sul perché conviene scegliere una fidanzata dell’Est.
E pensare che proprio ieri un amico mi aveva parlato con entusiasmo del suo matrimonio a Bucarest di prossima data. Ora chi lo dice ad Alexandra, sua futura sposa e promettente psicologa over 30, che in Italia la Televisione di Stato è schiavizzata dal fetido maschilismo del bar sotto casa e dal populismo ad oltranza?
Forse il migliore modo per risarcire noi che paghiamo il canone RAI – finiamola con la solita tiritera che si tratta di una tassa sulla tv (se così fosse dovrebbe essere equamente distribuito a tutte le emittenti) – sarebbe sostituire lo spazio occupato dalla Perego, oggi capro espiatorio di tante altre zolle in cancrena del palinsesto, con una serie di ritratti delle donne dell’Est Europa nell’ultimo cinquantennio, affidati a firme autorevoli del giornalismo italiano. Sarebbe un’opportunità per affossare pregiudizi, curare il nostro strabismo.
La mia generazione ha dovuto aspettare la caduta del muro di Berlino per iniziare a dialogare e riconoscere da vicino la bellezza della gente dell’Est, vissuta nei miei on the road che mi hanno portato da Sarajevo a Belgrado, da Tirana a Bucarest, da Varsavia a Sofia.
Ci sono tanti modi per far violenza su una donna. La puntata di Parliamone Sabato è uno di questi. A viale Mazzini le mimose sono appassite da un bel pezzo.