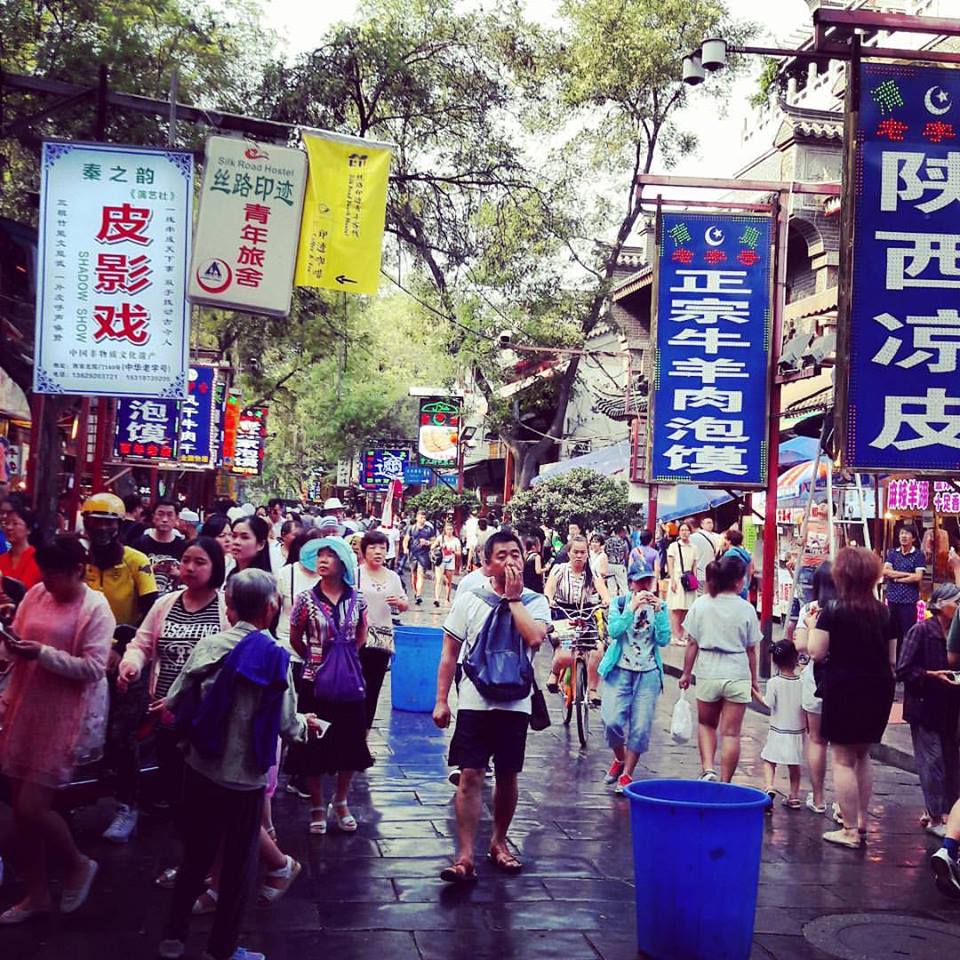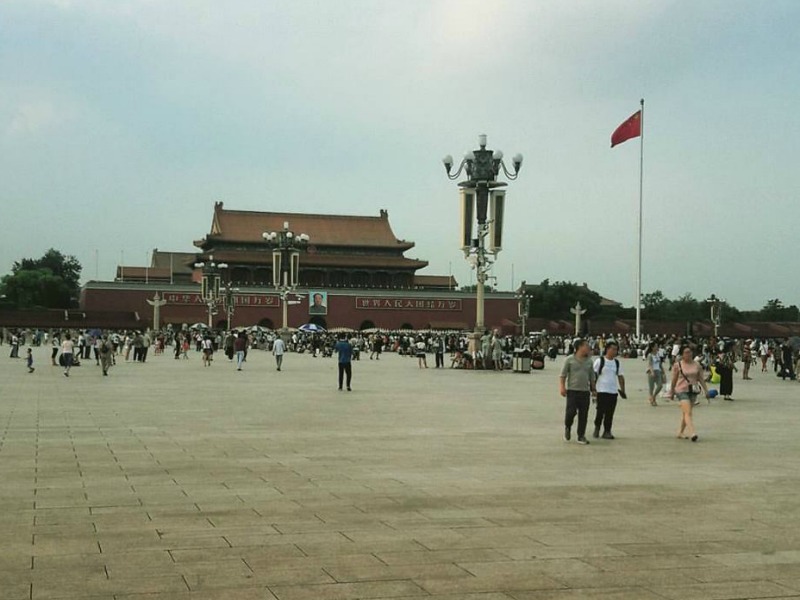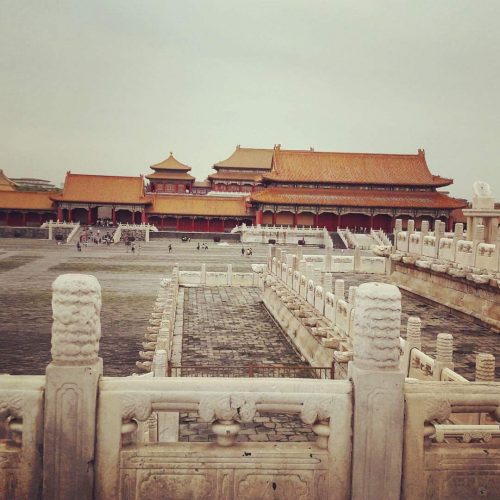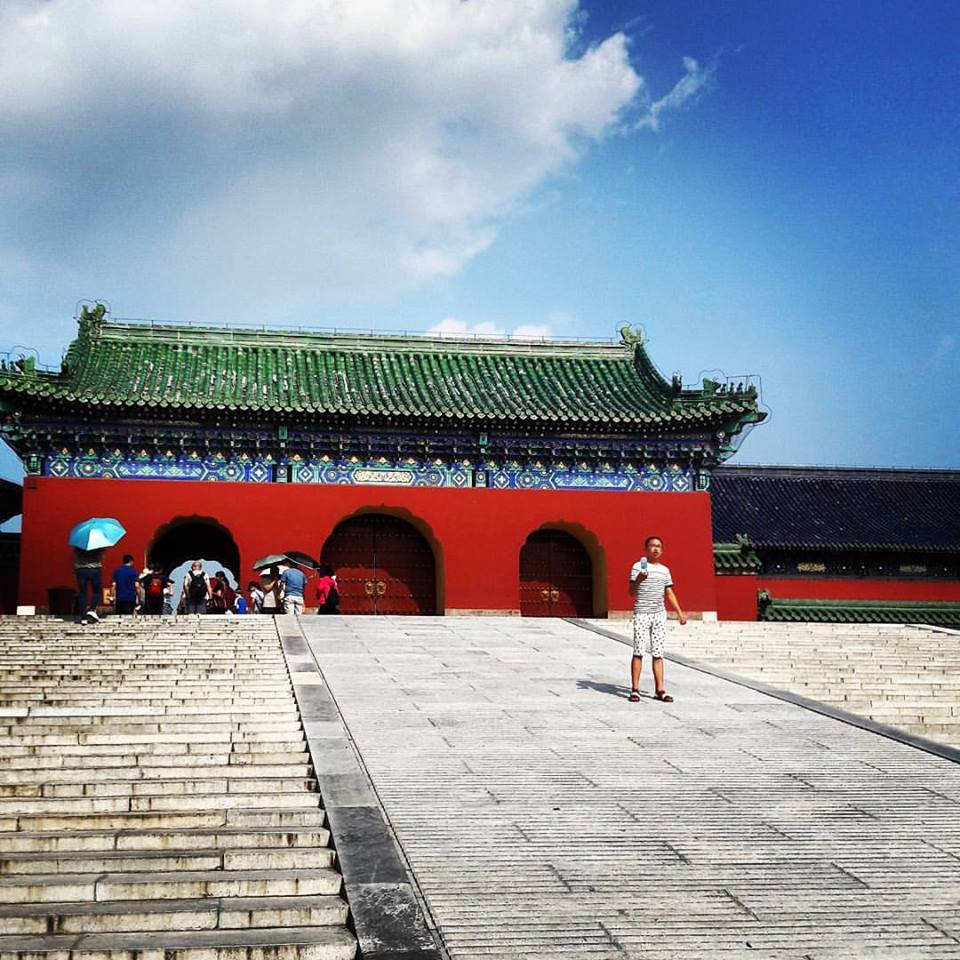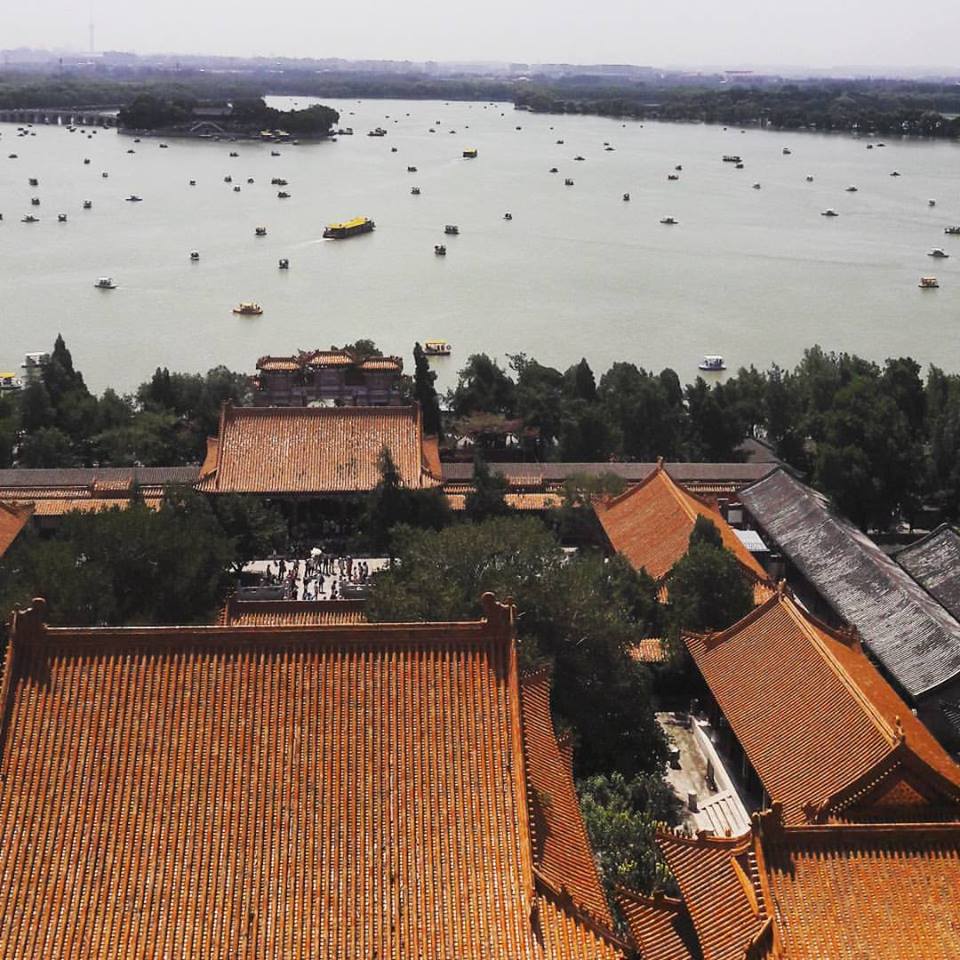Da “Amare significa non dover dire mai mi dispiace” a “Ya Pihi Irakema”
 La generazione dei miei genitori, sposata all’alba degli anni ’70, fu benedetta da questa citazione di Erich Segal: “Amare significa non dover dire mai mi dispiace”. In realtà non era una frasetta accartocciata nei Baci Perugina, ma una battuta cruciale del cult movie Love Story che spopolò al cinema con Ryan ‘O Neal e Ali MacGraw, diventando un bestseller negli scaffali delle librerie.
La generazione dei miei genitori, sposata all’alba degli anni ’70, fu benedetta da questa citazione di Erich Segal: “Amare significa non dover dire mai mi dispiace”. In realtà non era una frasetta accartocciata nei Baci Perugina, ma una battuta cruciale del cult movie Love Story che spopolò al cinema con Ryan ‘O Neal e Ali MacGraw, diventando un bestseller negli scaffali delle librerie.
DIVORZI – Quella generazione fu travolta da un incremento pauroso dei divorzi – secondo l’Istat in Italia si passò dai 12 mila del 1980 ai 28 mila del 1990 – ritrovandosi disillusa con una “frase del cacchio” tra le mani. Forse più che rincorrersi nella New York che faceva da sfondo al popolare melodrammone, le coppie di allora si sarebbero dovute accalcare al confine tra Venezuela e Brasile, dove vive il gruppo indigeno degli Yanomamo.
CONTAMINAZIONI – Per le coppie di oggi sarebbe più facile sguazzare nel Rio delle Amazzoni e sentire tra gli alberi un vocio che declama “Ya Pihi Irakema” e che letteralmente significa “Sono stato contaminato da te”. Per farla breve, questo è il modo degli indigeni per dire il nostro occidentale “Ti amo”, sgualcito e maltrattato dalla nostra superbia progressista.
NOI – In realtà, se ci pensiamo bene, non ci lasciamo mai sedurre dalla “contaminazione dell’altro”, ma finiamo con l’accontentarci della “mescolanza”. Non è la stessa cosa. Quando ci mescoliamo finiamo sempre per vivere l’altro nella prigionia di una corazza blindata. La contaminazione ci fa ritrovare l’infinita bellezza del contagio, della crescita e dell’evoluzione dell’io nell’altro, che poi fa maturare il “noi”.
SAGGEZZA INDIGENA – “Amare significa non dover dire mai mi dispiace” è stato l’epitaffio di quella generazione che dal “Ti amo” da fidanzati è passata al “Figlio mio, lascia perdere tua mamma che non capisce un cazzo!” da sposati.
“Ya Pihi Irakema”, perla della saggezza indigena, è la speranza ed è un lusso che dovremmo concederci nell’arte di amare.
Una parte di te è entrata in me, dove vive e cresce. (David Servan-Schreiber)