Last Christmas e il pop controverso di George Michael

 La canzone beffa, “Last Christmas”, l’inno natalizio dietro cui si è nascosta un’intera generazione, alla deriva sulla zattera dei pirotecnici e vuoti anni ’80. Era scritto subdolamente nei versi di questo 45 giri da milioni di copie vendute che la vita di George Michael si sarebbe fermata sulle note di “l’ultimo Natale”. In questo perfido anno bisestile che si è portato via Bowie, Prince , Coehen, la stessa sorte è toccata anche a George all’età di 53 anni nel pomeriggio del 25 dicembre di Natale. Le fonti ufficiali parlano di infarto, ma i dubbi restano sulla scomparsa improvvisa del musicista britannico.
La canzone beffa, “Last Christmas”, l’inno natalizio dietro cui si è nascosta un’intera generazione, alla deriva sulla zattera dei pirotecnici e vuoti anni ’80. Era scritto subdolamente nei versi di questo 45 giri da milioni di copie vendute che la vita di George Michael si sarebbe fermata sulle note di “l’ultimo Natale”. In questo perfido anno bisestile che si è portato via Bowie, Prince , Coehen, la stessa sorte è toccata anche a George all’età di 53 anni nel pomeriggio del 25 dicembre di Natale. Le fonti ufficiali parlano di infarto, ma i dubbi restano sulla scomparsa improvvisa del musicista britannico.
Il pop di George Michael ha cavalcato onde fatte di alti e bassi, addolcendo una generazione troppo distante dal rock graffiante e ribelle degli anni ’70 per ammettere che bisognava accontentarsi, che gli incentivi musicali andassero presi con le pinze.
I Wham furono pop disimpegnato nell’Inghilterra Thatcheriana che non voleva ribelli tra i piedi e la conservatrice Lady di Ferro si accorse che al numero 10 di Downing Street persino la servitù se ne sbatteva degli impolverati canti natalizi londinesi pur di canticchiare “Last Christmas, I gave you my heart but the very next day, you gave it away”.
Il canzoniere dei Wham galoppò classifiche di tutto il mondo, ma la voce di George Michael fece battere il cuore agli dei con due esibizioni che hanno scritto due pagine di storia della musica live: Don’t Let the Sun Going Down On Me con Elton John nel 1991 e Somebody to Love con i Queen nel 1992.
Geroge Michael si reinventò tra scivoloni di dance pop e soul bianco all’alba degli anni ’90, alla ricerca di una maturità musicale offuscata dalla vita privata: la morte del compagno a causa dell’AIDS, la depressione, il silenzio, il coming out arrivato soltanto alla fine del decennio. Ribadì in diverse circostanze: “Definisco la mia sessualità nei termini delle persone che amo”.
I legionari del pop oggi lo rimpiangono non tanto per la coralità di “Last Christmas”, quanto perché fecendo due conti in tasca hanno visto che anche la musica disimpegnata politicamente può spalleggiare ribellione: contro le dittature dei discografici, contro il patimento del vivere per apparire, contro chi impone l’ascolto della ragione e non del cuore per capirci qualcosa in più della vita.
Apostolo di questa ribellione controversa è stato George Michael, morto prematuramente tra le braccia dell’Inghilterra post-Brexit frantumata in pezzi.



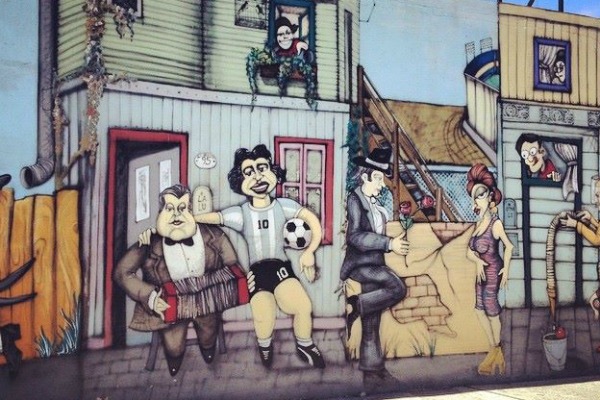
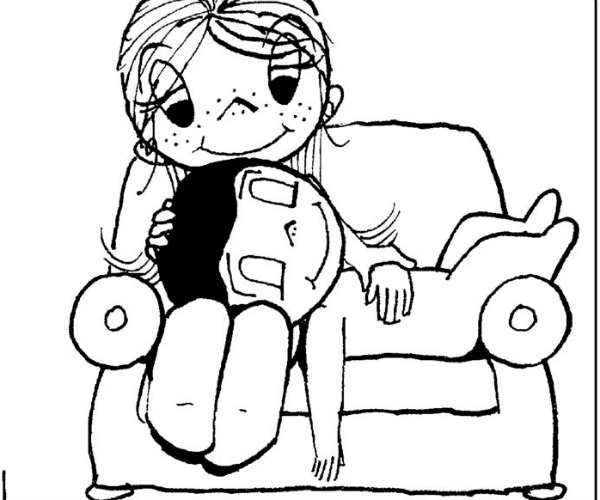



 Ciascuno di noi è stato terremotato almeno una volta nella vita. Chi più, chi meno, perché questa diventa una condizione dell’essere che va oltre un sisma. Dalle mie parti lo fummo dopo il terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980. Nel napoletano ce la cavammo con crepe nelle mura di casa e noi bambini riuscimmo a mettere in salvo l’unico bottino dell’infanzia, la scatola di giocattoli che numerava una per una le nostre Befane.
Ciascuno di noi è stato terremotato almeno una volta nella vita. Chi più, chi meno, perché questa diventa una condizione dell’essere che va oltre un sisma. Dalle mie parti lo fummo dopo il terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980. Nel napoletano ce la cavammo con crepe nelle mura di casa e noi bambini riuscimmo a mettere in salvo l’unico bottino dell’infanzia, la scatola di giocattoli che numerava una per una le nostre Befane.
