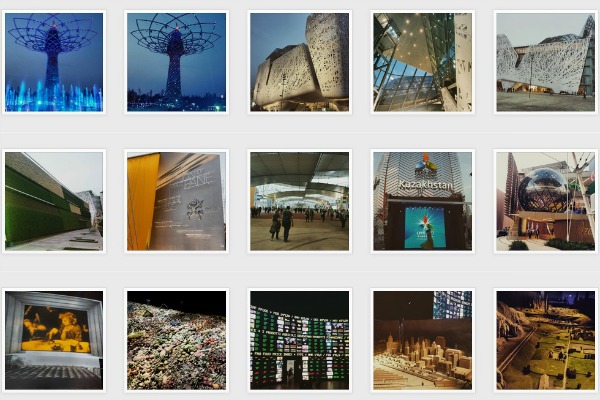Storie di casa mia: Antonio, il guerriero su due ruote

![]() Quando alla fine degli anni ’80 i miei genitori cambiarono condominio e quartiere, entrarono nella mia vita nuove persone. Sono i volti che nascondono storie e solo in apparenza sembrano comparse della nostra vita. In realtà alcuni di loro ne diventano incosapevolmente coprotagonisti, dando consistenza alla “nostra esistenza da mendicanti”.
Quando alla fine degli anni ’80 i miei genitori cambiarono condominio e quartiere, entrarono nella mia vita nuove persone. Sono i volti che nascondono storie e solo in apparenza sembrano comparse della nostra vita. In realtà alcuni di loro ne diventano incosapevolmente coprotagonisti, dando consistenza alla “nostra esistenza da mendicanti”.
Sì, perchè siamo luridi mendicanti tutte le volte che viviamo sotto il ricatto della distrazione. Durante gli anni del liceo scoprii che dietro il sorriso di Antonio si insidiava la sclerosi multipla: minacciosa, lenta, improvvisamente aggressiva. Furono la strada e il nuovo quartiere a farmi affacciare nella sua vita.
Nei giorni a ridosso della maturità era Antonio che mi incoraggiava, lì sulla sua carrozzella. Con Antonio non si facevano discorsi banali da macchinetta del caffè: si parlava di progetti, di sogni, di politica, di Dio, di filosofia spicciola infusa di quotidianità. Antonio era più grande di me ma aveva tanti bei sogni sul comò.
Mi piacevano di lui la sana ironia e il sarcasmo, perchè fanno di un giovane intelligente anche un uomo di buona fede. In un pomeriggio di maggio, a pochi mesi dalla mia laurea, mi chiese di spingerlo in carrozzella fino al supermercato. Tappai limbarazzo, io avevo l’uso delle gambe e lui no. Antonio lo capì e mi spiazzò, dandomi una bella lezione: “Prestami le gambe, spingi, spingi, non avere paura”.
In quell’istante presi coscienza del fatto che Antonio fosse un guerriero impavido e coraggioso, che con la sua passione per la vita metteva a tappeto giorno dopo giorno la sclerosi multipla. Antonio aveva da dare tanto a tutti noi “mendicanti distratti dalla routine”.
Dopo il trasferimento a Milano, io e Antonio ci siamo persi di vita. Ci siamo ritrovati la scorsa notte quando, fuori da un supermercato, è sbucato un carrello vuoto e abbandonato. L’ho afferrato, ho iniziato a spingerlo furiosamente tra rabbia e dolore, nel buio della notte tra i semafori lampeggianti, come se fosse la carrozzella di Antonio. Sapevo che il guerriero su due ruote non poteva rispondermi più.
Vent’anni fa prestai le gambe ad Antonio. La scorsa notte ha ricambiato il prestito altrove, a pochi passi da dove vivo oggi: il ricordo del sorriso del guerriero su due ruote ha schiaffeggiato mie lacrime da quarantenne bagnate dalla pioggia, ricordandomi che la bellezza di Dio sedeva accanto ad Antonio, amico di quartiere, su quella carrozzella.