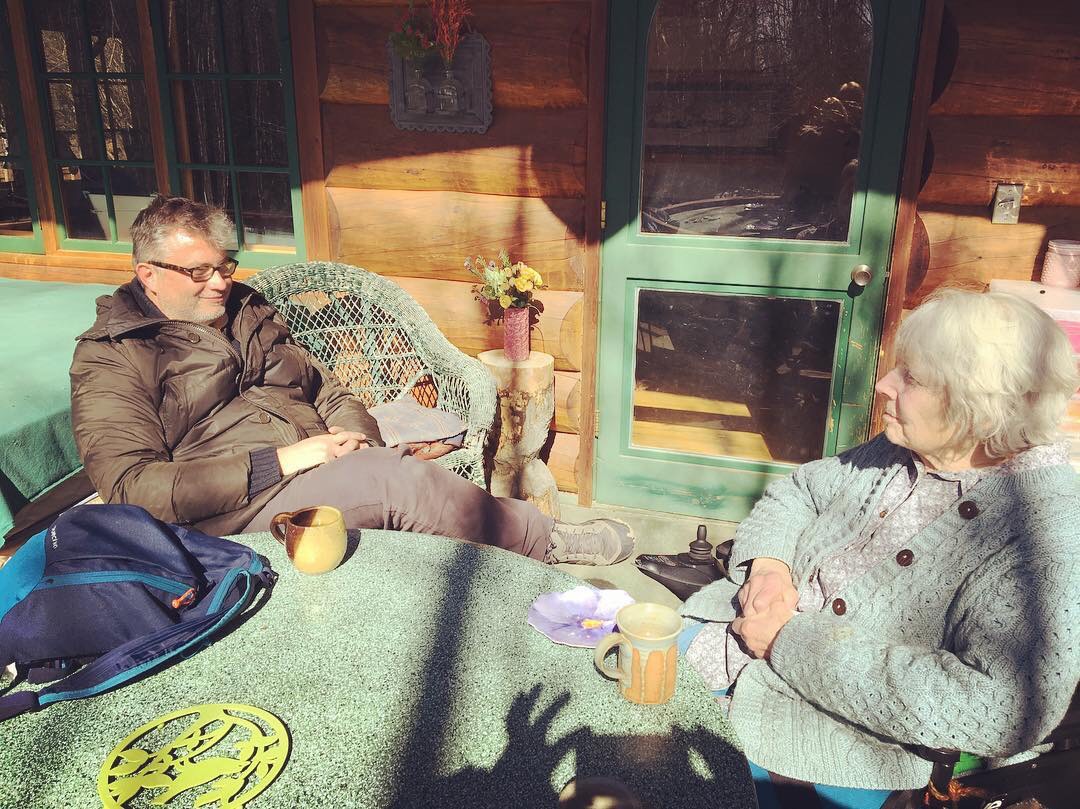La Genova di De André nel silenzio della pandemia

Genova per noi nel silenzio della pandemia, come se questo viaggio di ritorno in una delle città che più mi appartiene fosse una soffusa liberazione dalle catene dei lockdown a colori. La mascherina agevola la mescolanza nel flusso di coscienza della comunità e, allo stesso tempo, impedisce alle mandibole e al respiro di muoversi liberamente. Il mondo di Fabrizio De André diventa la tua ombra, passo dopo passo.
DAL LETAME NASCONO I FIOR
In via del Campo – conosco a memoria ormai ogni angolo – di Bocca di Rosa neanche il fantasma e mi chiedo abbassando lo sguardo quanto tempo Faber abbia impiegato per scrivere quella strettoia poetica divenuta patrimonio dell’umanità: “Dai diamanti non nasce niente Dal letame nascono i fior“.
C’è sempre qualcosa che profuma di De André in questo silenzio pandemico e surreale, in questo vuoto dei crocieristi di un tempo sbarcati dalle navi con l’affanno di collezionare selfie: “Come è bello il mare, quanto dura una stanza. È troppo tempo che guardo il sole, mi ha fatto male”.
IN UNA MULATTIERA DI MARE
Risponderebbe l’altra anima salva, Ivano Fossati, che “Chi guarda Genova sappia che Genova Si vede solo dal mare Quindi non stia lì ad aspettare Di vedere qualcosa di meglio, qualcosa di più”.
Sì, tutto viene fuori per ritornare nel mare, come quello del viaggio musicale di Faber e Mauro Pagani in Creuza de mä, uno degli album più pittorici della nostra discografia:
E ‘nt’a barca du vin ghe naveghiemu ‘nsc’i scheuggi
emigranti du rìe cu’i cioi ‘nt’i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d’a corda marsa d’aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta ‘nte ‘na creuza de mä.
STAGLIENO
Tradurre questo genovese è una bestiemma, sembra quasi di sbucciare la poesia: “E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli emigranti della risata con i chiodi negli occhi finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere fratello dei garofani e delle ragazze padrone della corda marcia d’acqua e di sale che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare.“
Sì, tutto ritorna nel mare, come le ceneri di Faber. E quando mi perdo nel cimitero monumentale di Staglieno, tra il ricordo risorgimentale di Mazzini e l’incontro indimenticabile con Nanda Pivano, mi rendo conto che è una lurida sciocchezza cercare De André oltre una lapide gelida, adesso che le sue ceneri appartengono al mare di Genova, che la difesa del suo patrimonio cantautoriale rimane un faro nella traversata del vuoto di oggi e delle sue strambe ovvietà.
NEL SILENZIO DELLA PANDEMIA
La Genova di De André nel silenzio della pandemia mi appartiene comunque e non occorre essere un genovese di razza per notare le ambulanze senza sosta, che in direzione del Pronto Soccorso del San Martino ci raccontano anche che la guerra contro il Covid è ancora in corso e non bisogna smettere mai di abbassare la guardia. Eppure in questo silenzio struggente, amalgamato al mondo poetico di Fabrizio De André, c’è un mucchio di luride parole che dissacra la memoria delle vittime del Ponte Morandi:
“Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questo ponte mi han detto: ‘Fai l’analisi dei rischi catastrofali’. E io: ok”.
Questa intercettazione del 28 marzo 2019, che incastra l’incaricato di classificare il rischio del ponte crollato con 43 vittime, rimbomba nella Genova pandemica e batte l’ennessimo colpo d’ascia alle famiglie delle vittime e a tutti noi che aspettiamo giustizia.






 Lorena arrivò in Alaska nel 1965 ancora in fasce. Anchorage, l’ultima città del mio incredibile viaggio nell’ultima frontiera, ha fatto da ponte di collegamento con tutto il Centro e Sudamerica, accogliendo tante famiglie immigrate. Lorena è di origine messicana, è cresciuta qui e oggi fa l’artigiana: veste con pelliccia bambole eschimesi che sono per me un souvenir fatto a mano da portar via da un luogo sempre snobbato, perché considerato poco alaskino.
Lorena arrivò in Alaska nel 1965 ancora in fasce. Anchorage, l’ultima città del mio incredibile viaggio nell’ultima frontiera, ha fatto da ponte di collegamento con tutto il Centro e Sudamerica, accogliendo tante famiglie immigrate. Lorena è di origine messicana, è cresciuta qui e oggi fa l’artigiana: veste con pelliccia bambole eschimesi che sono per me un souvenir fatto a mano da portar via da un luogo sempre snobbato, perché considerato poco alaskino.