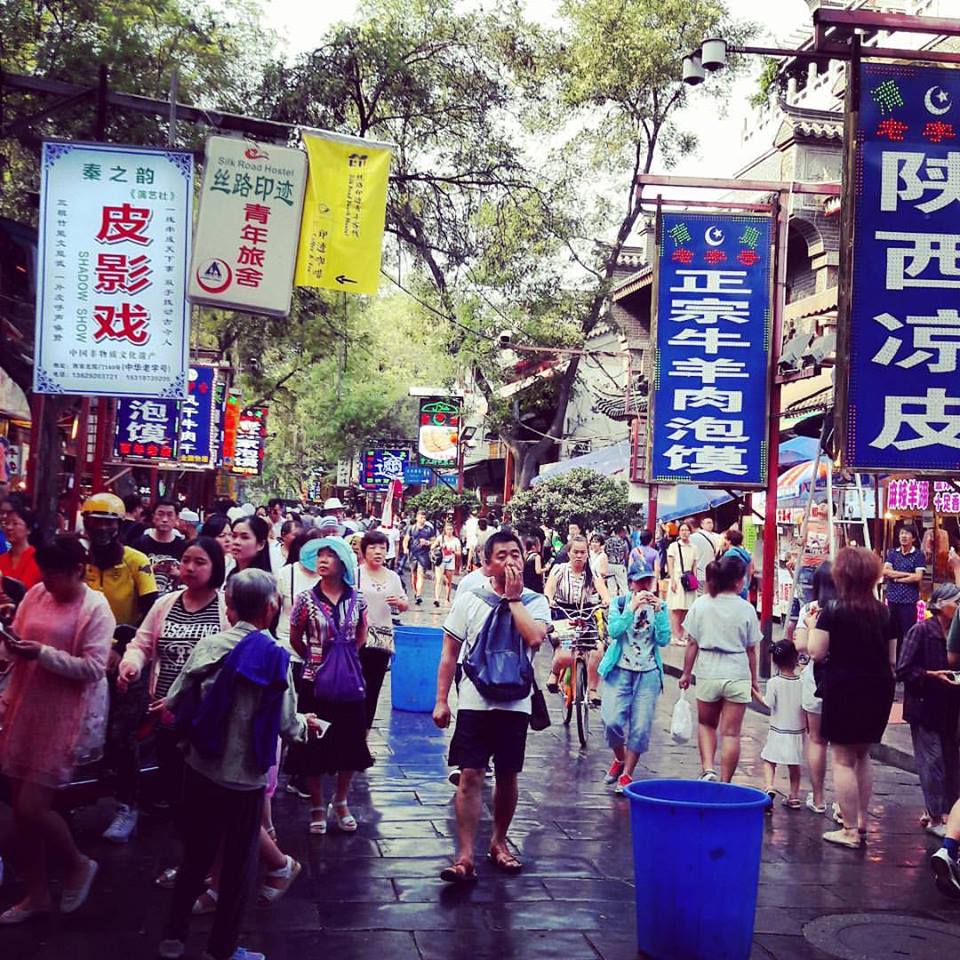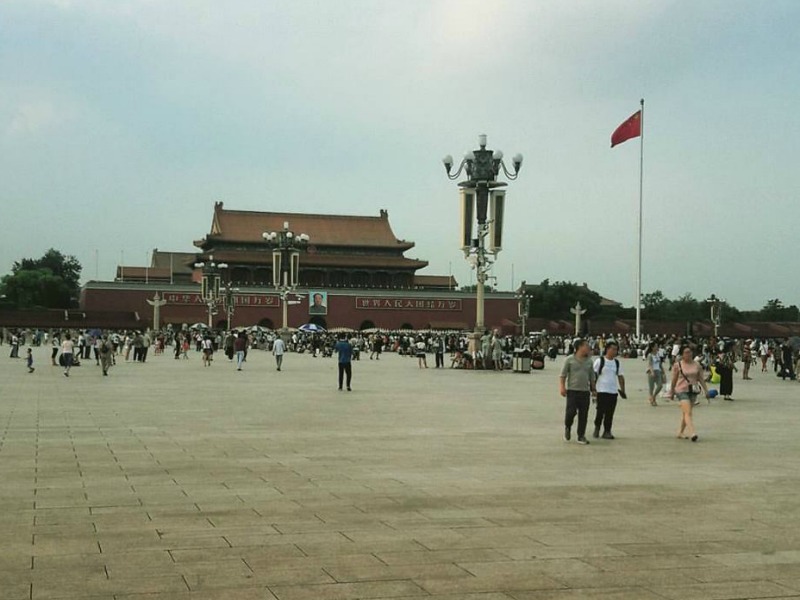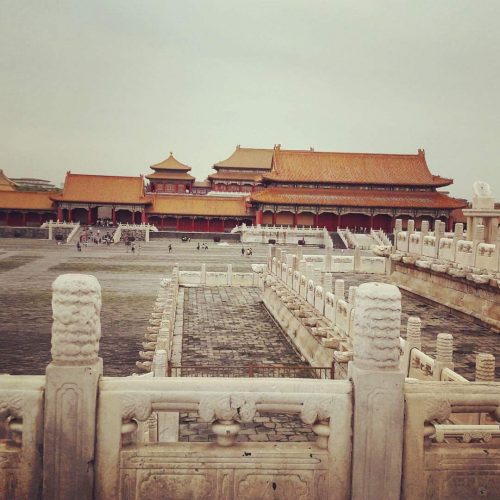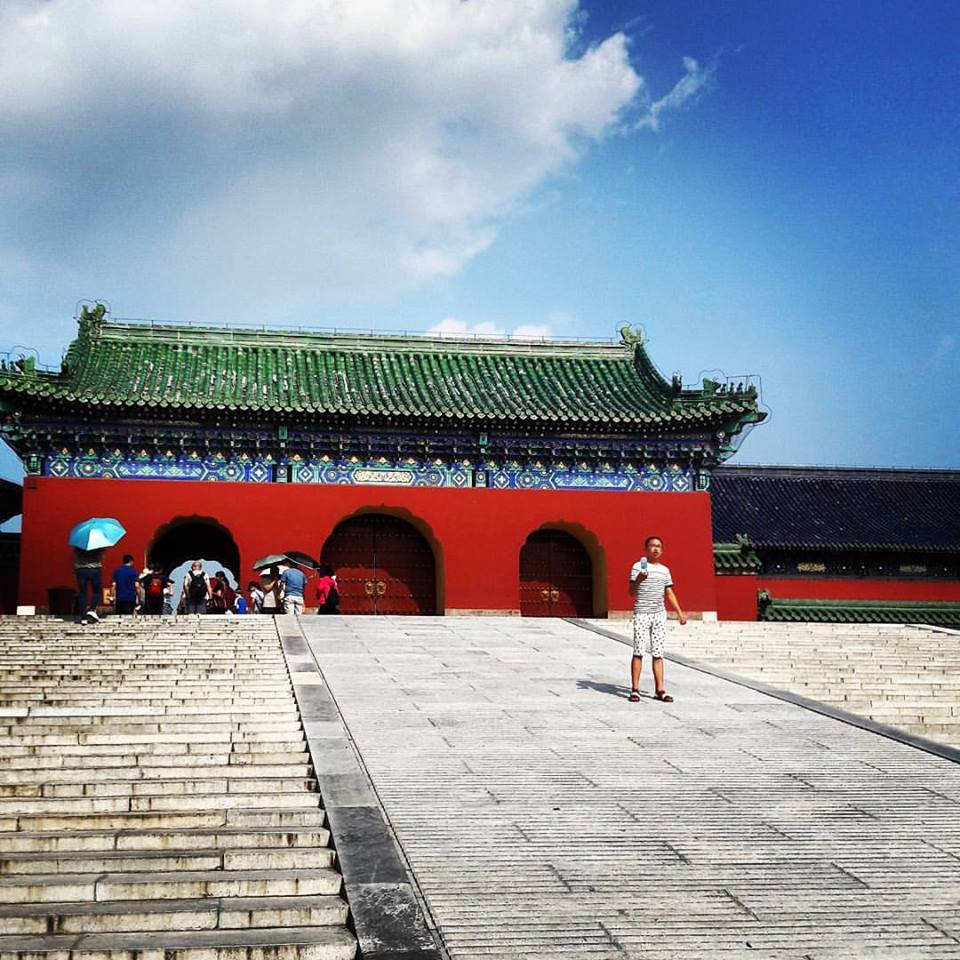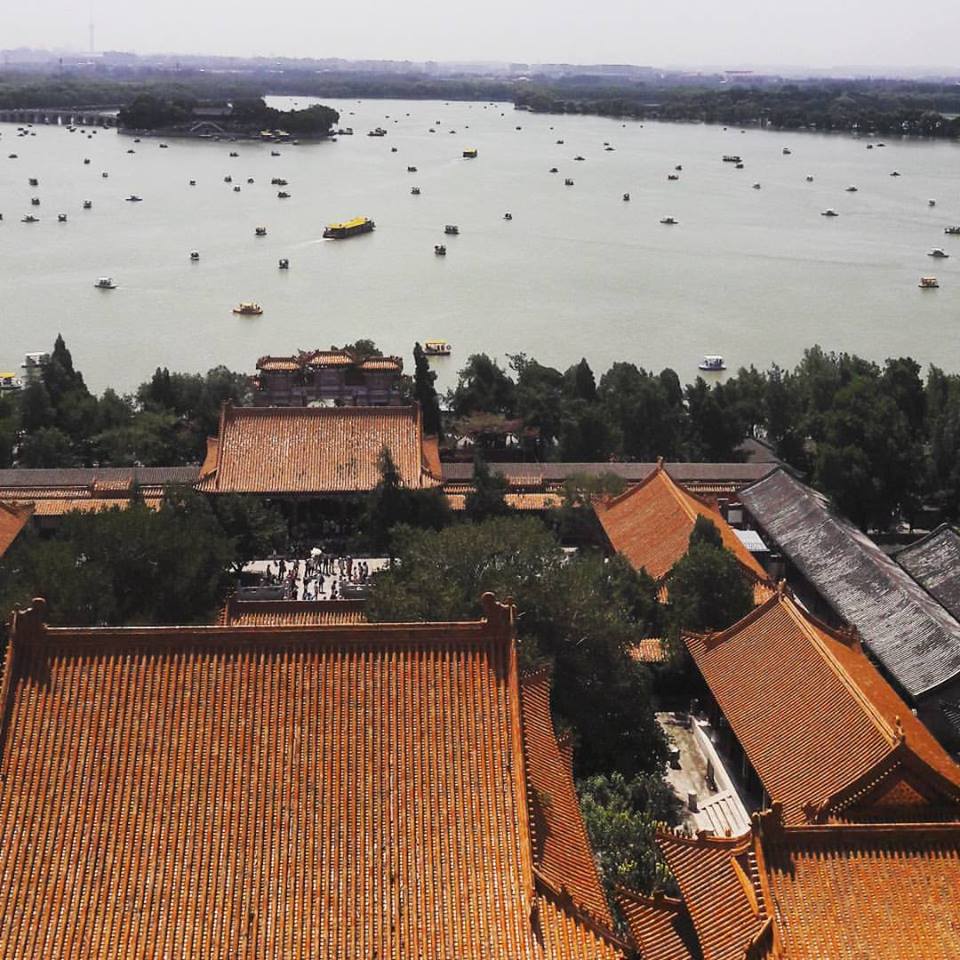Cartolina da Agra: l’amore eterno custodito dal Taj Mahal

 C’è ancora una mezza luna che brilla ad Agra. Non manca tanto alle prime luci del sole. Il Rajasthan è ormai alle spalle e nella regione indiana dello Uttar Pradesh sanno bene che bisogna arrivare prima dell’alba al Taj Mahal, affinchè la folla dei visitatori non faccia da gustafeste alla visita di una delle sette meraviglie del mondo.
C’è ancora una mezza luna che brilla ad Agra. Non manca tanto alle prime luci del sole. Il Rajasthan è ormai alle spalle e nella regione indiana dello Uttar Pradesh sanno bene che bisogna arrivare prima dell’alba al Taj Mahal, affinchè la folla dei visitatori non faccia da gustafeste alla visita di una delle sette meraviglie del mondo.
Quando l’imperatore moghul Shah Jahan fece costruire il mausoleo in memoria della moglie preferita Mumtaz Mahal, l’India del XVII secolo non poteva di certo immaginare che questo sarebbe diventato il simbolo del Paese.
Incamminandomi verso il gioiello UNESCO, che a seconda della luce del sole veste sfumature colori diversi, mi sembra di rivedere le centinaia e centinaia di elefanti impiegati e fatti morire per trasportare il materiale per la costruzione.
Ciascuno di noi in pellegrinaggio in questo luogo si sente custode dell’amore eterno, perché le tombe dell’imperatore e della sua amata non sono altro che la sfida alla nostra esistenza segnata dall’epitaffio “finché morte non ci separi”.
Il Taj Mahal è l’ultimo baluardo dell’umanità convinta che l’amore per la propria donna, nonostante tutto, sia infinito nell’evoluzione che lo conduce a crescere, espandersi in tutte le fasi, dalla giovinezza alla vecchiaia.
Il Taj Mahal, attraverso la sua ala protettiva, libera questo amore eterno dalle convenzioni sociali che hanno affossato l’India sotto i ricatti delle caste.
Le convenzioni sociali non risparmiano nessuno di noi, nella lotta quotidiana ai ricatti degli assurdi e mostruosi riti sociali che vorrebbero dettare legge sulla nostra vita. Il turista se ne va con un mucchio di selfie in tasca, surrogati del narcisismo volgare dei social network.
Il viaggiatore si ritrova accovacciato in silenzio dinanzi al Taj Mahal, perchè l’amore resta un mistero così come la morte.
L’amore non bada a caste né il sonno a un letto rotto. Io andai in cerca d’amore e mi persi. (Proverbio indù)