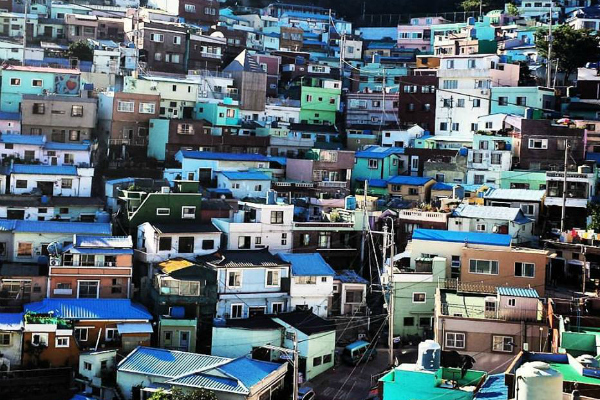Viaggio al Club Tenco, in quello scalo merci della vecchia ferrovia

 A Sanremo improvvisamente gli spifferi autunnali sono diventati miti. Mi sembra di rivedere mia madre quando ne approfittava per ristendere fuori il bucato. Da qualche anno la nuova sede del Club Tenco, fondato da Amilcare Rambaldi nel ’72 insieme a tanti missionari della cultura per la canzone d’autore, è l’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria sanremese. Preferisco questa a quella nuova con i binari seminterrati, anonima e amorfa.
A Sanremo improvvisamente gli spifferi autunnali sono diventati miti. Mi sembra di rivedere mia madre quando ne approfittava per ristendere fuori il bucato. Da qualche anno la nuova sede del Club Tenco, fondato da Amilcare Rambaldi nel ’72 insieme a tanti missionari della cultura per la canzone d’autore, è l’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria sanremese. Preferisco questa a quella nuova con i binari seminterrati, anonima e amorfa.
Entrando in sede senza pass, nessuno mi riconosce da addetto ai lavori. Sono tutti indaffarati con gli incontri del programma del Premio Tenco. Mi fermo nell’angolo dove ci sono un divano e una libreria. Mi sembra di esserci tornato dopo chissà quanto tempo, In realtà è la mia prima volta al Club Tenco.
Quando non esistevano i blog, noi giornalisti chiudevamo a chiave nello sgabuzzino i nostri diari di viaggio, come se articoli o reportage non avessero un backstage. In realtà non è mai stato così, soprattutto per noi che abbiamo scritto di spettacolo. Nei miei archivi inzuppati di carta giacciono interviste e tra foto e locandine appese alla parete del Club Tenco ritrovo gli incontri con Gaber, Vecchioni, Guccini.
Da una parte su un giradischi danza un vinile con le canzoni di Luigi, sugli scaffali della parete opposta ci sono l ultime annate di Il Cantautore, la monografia che da quarant’anni accompagna il programma del Premio dedicato alla memoria del cantautore scomparso il 27 gennaio del ’67.
La carta ingiallisce, ma non va mai a male, come le riflessioni sulla Resistenza in un numero di qualche anno fa. Tutti “partigiani della cultura” gli affiliati al club Tenco perchè hanno fatto della Resistenza una condizione del divenire, a difesa della canzone d’autore in un’Italia smemorata, che spesso dimentica, a volte addirittura rinnega.
In un certo senso lo è stata anche mia madre partigiana di questa Resistenza musicale: Alla fine degli anni ’70 tra profumi di bucato e detersivo aprì nella mia infanzia il varco sul canzoniere di Luigi Tenco, distillando a misura di bambino la rivoluzione di questo cantautore del futuro. Se non fosse stato per lei, le mie stagioni musicali si sarebbero arenate, per questioni anagrafiche, sul pop degli anni ’80 e sugli ingorghi musicali del riflusso.
Dall’altra parte del divano incrocio lo sguardo di Toni, il papà dell’Ala Bianca che salvaguarda il patrimonio musicale del Tenco. Lo ricordo ai tempi dello Smeraldo a Milano – allora un teatro valeva più di un food store destinato alla Milano radical-chic – in camerino che parlottava con Enzo e Paolo Jannacci.
Tra una polaroid e l’altra, mi avvisano che devono chiudere la sede. Il tempo è volato. Mi sarei fatto rinchiudere dentro, avrei continuato a divagare tra letture o chiacchierando con Enrico De Angelis per farmi raccontare per filo e per segno questo viaggio quarantennale.
All’uscita, mi ritrovo fronte mare sulla riviera ligure tra gli ultimi fili di luce. Ci sono tre coppie su una panchina che chiacchierano. Tiro fuori lo smartphone, colgo uno scatto al volo, lo pubblico senza filtri su Instagram. Mi piace questa foto e la titolo “Ho capito che ti amo”, proprio come la canzone di Tenco che veniva fuori dal giradischi nel vecchio magazzino dell’ex stazione ferroviaria di Sanremo.
“Ho capito che ti amo” non è soltanto la consapevolezza di un sentimento longevo e duraturo alle intemperie del tempo, è anche un lucido riconoscimento verso chi ha nutrito amore nei confronti di una cultura musicale che ci ha fatti tutti militanti dell’esistenzialismo, guardandoci dentro senza i filtri fasulli della vita digitale, prima di approdare a quella gaberiana della “libertà è partecipazione”.