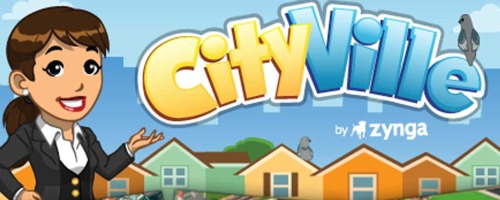Il bacio da Facebook in una cannuccia. Non ci cascate perché non fa più filù filù filù filà

 Sì, è vero: baciare è un’arte, ma è anche uno dei momenti a cui una coppia non dovrebbe mai rinunciare. Spesso lo si affronta con una tale sfacciataggine o leggerezza da privarsi del risveglio di quel gesto. Un bacio non è forse lo scrigno segreto che custodisce il sapore, la fisicità e la fragranza della dolce metà? Adesso sarà davvero dura spiattellare a tutti gli autori che lo hanno messo in versi– da Catullo a Cesare Pavese, da Alda Merini a Jaques Prevert – l’amara verità. Nell’euforia dei rapporti virtuali che nascono e muoiono nella rete dei social network, ecco che arriva quello che potremmo tranquillamente battezzare come il bacio da Facebook. Una diavoleria che i giapponesi vogliono metterci in testa, anzi direi “in bocca”: il Kiss Trasmission Device, uno strano aggeggio che, attraverso una cannuccia, ci fa baciare chi sta dall’altra parte dello schermo. Come? Muoviamo la lingua e poi sarà il PC ad elaborare il tutto e trasferirlo alla persona amata. E chi sta dall’altra parte, si attacca alla cannuccia, ricambia e i sensori computerizzati provvedono alla trasmissione.
Sì, è vero: baciare è un’arte, ma è anche uno dei momenti a cui una coppia non dovrebbe mai rinunciare. Spesso lo si affronta con una tale sfacciataggine o leggerezza da privarsi del risveglio di quel gesto. Un bacio non è forse lo scrigno segreto che custodisce il sapore, la fisicità e la fragranza della dolce metà? Adesso sarà davvero dura spiattellare a tutti gli autori che lo hanno messo in versi– da Catullo a Cesare Pavese, da Alda Merini a Jaques Prevert – l’amara verità. Nell’euforia dei rapporti virtuali che nascono e muoiono nella rete dei social network, ecco che arriva quello che potremmo tranquillamente battezzare come il bacio da Facebook. Una diavoleria che i giapponesi vogliono metterci in testa, anzi direi “in bocca”: il Kiss Trasmission Device, uno strano aggeggio che, attraverso una cannuccia, ci fa baciare chi sta dall’altra parte dello schermo. Come? Muoviamo la lingua e poi sarà il PC ad elaborare il tutto e trasferirlo alla persona amata. E chi sta dall’altra parte, si attacca alla cannuccia, ricambia e i sensori computerizzati provvedono alla trasmissione.
La tecnologia ci sta dando davvero così alla testa da trasformare una meraviglia in un gesto bionico per farci assomigliare sempre più ad una macchina. E questa, ahimé, non è fantascienza., ma un bizzarro tentativo di chi vorrebbe convincerci che pure un bacio non debba fare più “filù filù filù filà”.