Caro vecchio divano…

 Quando mi sono disfatto del vecchio divano e sono venuti a ritirarlo per far spazio a quello nuovo, ho visto un pezzo della mia vita andarsene via. Direte un divano?
Quando mi sono disfatto del vecchio divano e sono venuti a ritirarlo per far spazio a quello nuovo, ho visto un pezzo della mia vita andarsene via. Direte un divano?
Nessun attaccamento tipico del feticismo da amante d’arredamento. Anzi, se ci ripenso gli arredi della mia vita sono stati le fermate d’autobus, le panchine, gli angoli delle stazioni, le vecchie cabine telefoniche perché da viaggiatore mi hanno fatto conoscere altri viaggiatori della vita.
Quando ero piccolo il divano era rinchiuso nella lontana stanza-salotto che noi gente del Sud usavamo aprire soltanto nelle grandi occasioni. Otto anni fa mi trasferii nella nuova casa e volli il divano nel cuore del soggiorno con una penisola che il più delle volte finiva per ridursi a scrivania.
Per carità non sono un pantofolaio e i divani mi hanno sempre dato l’aria di quella pigrizia e noiosa indolenza da cui sono stato alla larga.
Per questo è stato diverso, la fodera è stata una sorta di moviola di condivisioni: ci sono passate decine e decine di persone che all’inizio lo scambiavano per un divano letto. Invece no, non era trasformabile, era un divano punto e basta.
E chi ci ha dormito in questi anni si è adattato con uno stato di provvisorietà che faceva dei cuscini presi a Londra, la città dove sono rinato da adolescente, e della coperta dell’ospite un barlume di provvisorietà che ti faceva sentire in un mini accampamento fatto in casa.
Quel divano, se ci ripenso, è stato l’isola che mi ha fatto viaggiare stando fermo: migliaia di vinili ascoltati, letture, film rivisti e poi bivaccato con le dita sulla tastiera del pc a scrivere, correggere, riscrivere, sbobbinando interviste, imbastendo i capitoli del mio romanzo, cacciando i biglietti per i nuovi viaggi, appuntando itinerari, scarabocchiando sogni della mia nuova vita in una terra che non era la mia. Chiacchierate e segreti condivisi con i miei interlocutori come se fosse la seduta di un talk show intimo per svelare la nostra specie in estinzione, avvinghiare aspettative, raggomitolare progetti futuri, cambiando magari posto perché la penisola ti permetteva di stendere le gambe.
Il divano era lì fermo e immobile a raccogliere vita su vita, pattumiera di sconfitte o sputafuoco di successi, notizie belle o brutte, il dolore immenso per la notizia di persona cara scomparsa, come una puntura endovena; la gioia nel vedere la tua nipotina, per la prima volta a casa, riconoscere nello spazio del divano la libertà negata da una minuscola culla.
E poi lo smaltimento di coccole e tenerezze tra lei che guardava la televisione nella zona della penisola ed io che puntualmente mi addormentavo sulle sue gambe senza mai riuscire a ricordare il finale del film.
Il pavimento è vuoto ora e c’è ancora il segno del vecchio divano. Spero che ritardino la consegna del nuovo. Non fraintendetemi, non è nostalgia per un pezzo d’arredo. E’ piuttosto la consapevolezza che un divano sa essere cantastorie ed io ho imparato ad usarlo come un tappeto volante sulla mia esistenza.





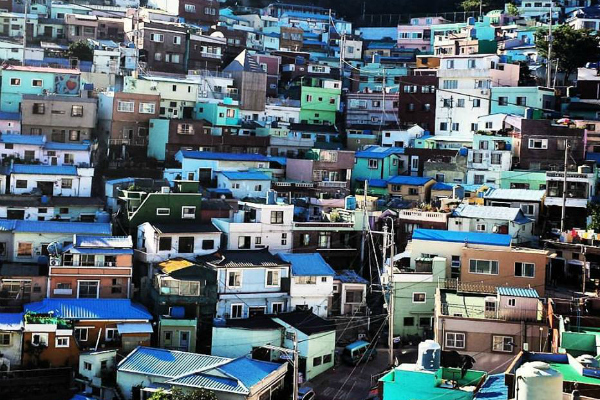

 Sono le 8 di sera e il sole è calato da un pezzo. Sono in questa viuzza di Kyoto, città custode della memoria del vecchio Giappone. Ti aspettavo, sapevo che saresti passata prima o poi. I turisti ficcanaso sono dall’altra parte e ti cercano solo per rubare uno scatto e fare gli spavaldi al ritorno, come se poi tu fossi un souvenir.
Sono le 8 di sera e il sole è calato da un pezzo. Sono in questa viuzza di Kyoto, città custode della memoria del vecchio Giappone. Ti aspettavo, sapevo che saresti passata prima o poi. I turisti ficcanaso sono dall’altra parte e ti cercano solo per rubare uno scatto e fare gli spavaldi al ritorno, come se poi tu fossi un souvenir.


